Marco Aime, Rubare l’erba. Con i pastori lungo i sentieri della transumanza, Ponte alle Grazie, Milano, pp. 115, 12 euro
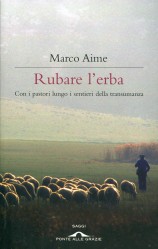
È vero: sono partiti tutti, da Roaschia, in Valle Gesso. Il paese era combinato così: «C’erano tre mestieri in pista: contadino, pastore e commerciante: tutti e tre ti portavano via, […] via da questo paese troppo stretto e ombroso. Da questa conca a cui la punta del Casternaut toglie il sole per tanti mesi l’anno». Se ne andavano gli üvernenc, i contadini, durante la stagione fredda, quando la neve copriva ogni cosa e le bocche diventavano troppe per le dispense magre. Coi loro fagotti si incamminavano chi verso il piano chi per la riviera francese: qualcuna a servizio, altri a raccogliere le mimose, molti a coltivare la terra di qualche “monsieur”, tutti a cercare di arrangiarsi per racimolare poche lire da riportare a casa («tutti i ponti della valle Roja li hanno fatti i ruas-cin»). Partivano i gratta, i pastori: d’estate per i pascoli generosi della Val Vermenagna, del Marguareis, della Valle Stura, della Val Chisone; in inverno per le cascine della pianura, da Chieri a Piacenza, a vendere il sairass, la ricotta, e a scambiare il letame con fieno e ospitalità. Partivano infine anche i pastori diventati commercianti di latte e derivati e andavano a riempire le Pagine gialle di Torino, Genova, Savona di latterie dai nomi inconfondibili: Aime, Barale, Fantino, Ghibaudo, Giraudo, …
Poi, negli anni ’50, dopo l’ultima guerra, sono arrivati altri mestieri a portare via i ragazzi dal paese, in molti casi per sempre: erano gli anni della ricostruzione e del boom economico e le industrie di Borgo, Cuneo e Torino avevano bisogno di operai. Fare il pastore o l’agricoltore in montagna costava troppa fatica e pagava poco. Erano i tempi in cui «l’Italia si scrollava di dosso il vecchio mantello da contadina e iniziava a vestirsi da cittadina. Appassivano i mestieri, appassiva la montagna tutta. Troppe macchine e troppo veloci per il passo lento delle pecore. […] Non c’era più posto per i pastori, non più strade per transumare. Non c’era più posto per i montanari in quel dopoguerra di orizzonti industriali». Un peccato? No, una trasformazione, forse avvenuta in modo troppo frettoloso e brutale. Ma d’altra parte «bisognerebbe prendere il fucile per quello che ha inventato il pastore! Non era un mestiere da fare!» «Io ho dei figli che lavorano in fabbrica e si trovano molto meglio che a fare il pastore» taglia corto Toni, che le pecore le ha tenute finché ha potuto e ha rischiato più di un incidente in macchina incantandosi alla vista di un bel prato lungo la strada. Le voci di Toni e Margherita, raccolte da Marco Aime in lunghe interviste davanti a un caffè, caricano il lettore sul cartun, sul carro, e lo portano a spasso tra la Lomellina e il mare, tra le montagne dei bergé, dei marché, dei cavié, degli anciuiè e il piano delle cascine e delle città.
Aime, antropologo alpino e africanista, era già salito a Roaschia qualche anno fa, per condurre insieme a Stefano Allovio e a Pier Paolo Viazzo una ricerca sui pastori transumanti (“Sapersi muovere. I pastori transumanti di Roaschia”, Bollati Boringhieri, Torino 2002). Ma prima ancora che in veste di studioso, Marco aveva risalito da bambino e da ragazzo i tornanti che dal Gesso portano al paese per trascorrere l’estate nel paese dei nonni, anche loro ruas-cin. Sarebbe fin troppo facile pensare a un ritorno alle radici, ma è proprio Aime a mettere il lettore in guardia da una metafora, quella delle persone come piante, che ci trasforma tutti in creature immobili e legate a un pezzo di terra. Per fortuna in fondo alle gambe le persone hanno i piedi e se ne sono sempre servite per spostarsi, spaesarsi e conoscere altre terre, incontrare persone diverse.
Preciso come un saggio ma piacevole come un romanzo, “Rubare l’erba” alterna memorie dei roaschini e ricordi dell’autore, citazioni di canzoni e versi di poesie, in un giocare di voci che dà luogo a improbabili incontri: il pastore errante dell’Asia e il pastore transumante di Roaschia, l’idillio pastorale di D’Annunzio e la prosaica realtà dei “ladri d’erba”, Francesco Guccini e Fernando Pessoa.
Di voce in voce, di aneddoto in aneddoto, si definiscono i contorni di un mondo in movimento fatto di pascoli e animali: «erba e pecore, questo regolava la vita del pastore». Erba da guadagnarsi con astuzia a spese degli altri pastori, erba di lembi marginali lungo i fiumi, erba di campi proibiti che si riusciva a rubare approfittando delle giornate di nebbia. Nomadi e un po’ ladri, «mai a casa, imbroglioni e scansafatiche» (il soprannome “gratta” non lascia adito a dubbi sull’opinione che i “sedentari” avevano dei pastori…): «come gli zingari, anche i pastori erano sempre in giro e sempre stranieri». Galeotti per necessità, non per cupidigia, i pastori erano d’altro canto “uomini di mondo”, che sapevano farsi capire dalle Graie all’Appenino, che avevano un gergo tutto loro per intendersi e una scuola estiva istituita apposta per permettere ai bambini di studiare, tra uno spostamento e l’altro. I pastori erano più svici, meno creduloni dei contadini ancora disposti a dar credito alle storie di masche. La loro era una vita raminga scandita dai ritmi degli animali e dal rincorrersi dei Santi sui calendari.
Oggi di pecore non se ne vedono più: un tempo «il posto dei pastori», oggi Roaschia è un posto e basta. Un piccolo comune con meno di cento abitanti, coi versanti sfregiati dalle ferite incurabili delle cave e i pochi pascoli coperti dall’avanzata di alberi e arbusti. Uno dopo l’altro, i pastori se ne sono andati tutti. Qualche mese fa, senza aver avuto nemmeno il tempo di leggere il libro, anche Toni, come direbbe un roaschino, “ha ammazzato il cane”: se n’è andato via.
Alla fine di “Rubare l’erba”, il lettore ha imparato molto della vita dei pastori roaschini e scoperto quasi altrettanto dell’autore. Tutti e due gli argomenti valgono senz’altro la lettura.
Irene Borgna










