Enrico Camanni, Il fuoco e il gelo. La Grande Guerra sulle montagne, Laterza 2014, 240 pp., 16 euro
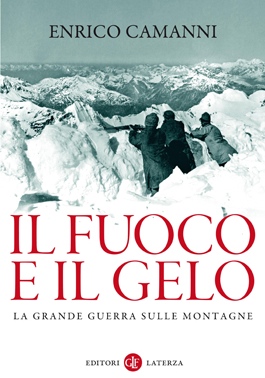
Alla fine della Grande Guerra quelli che tornarono non erano più gli stessi, né lo erano le famiglie dei molti che non erano tornati: 180.000 solo per quel che riguarda la “guerra bianca”, quella combattuta sulle montagne. Di essa avevamo già racconti parziali, ma bisognava aspettare questo libro per avere un quadro completo e illuminante di che cosa significò la Grande Guerra per i combattenti, per le montagne, per il loro e il nostro rapporto con esse. Quando la guerra finì anche le montagne non erano più quelle di prima, perché lo “sporco insieme di medioevo e di moderno” che fu questo conflitto non solo devastò i luoghi con le cannonate, le bombe, le mine, i chilometri di camminamenti, trincee e gallerie, ma modificò la nostra immagine della montagna. Sia di quella del conflitto, “altare da onorare”, meta di pellegrinaggi, adunate, commemorazioni che continuano tuttora con un turismo che è “rischiosa sovrapposizione del piacere di oggi al sacrificio di ieri”. Sia soprattutto la montagna in genere che, grazie alla retorica dell’alpino alpinista, diventerà palestra di igieniche fatiche e di ardimento per le masse.
Questa svolta epocale viene raccontata facendo interagire le storie delle persone – ricavate da diari, lettere e testimonianze varie – con i paesaggi e i luoghi in cui esse si sono svolte, lungo le centinaia di chilometri del fronte alpino dallo Stelvio alle prealpi Giulie. Luoghi dove ancor oggi “si percepisce quasi ovunque la presenza di un dramma sospeso, come se cent’anni non fossero bastati a cancellare”. Nel libro la montagna con le sue asprezze “assassine” (molte centinaia i morti sotto le valanghe) e il suo incanto è protagonista, sia per come agì sul corpo e sull’anima delle persone, sia per come, con le sue caratteristiche estreme “impose il suo codice alle ragioni del conflitto”. Per chi a -30 °C presidiava vette al di sopra dei 3000 “l’alba del nuovo giorno era già una vittoria”. Ma c’era anche chi rompeva la deprimente monotonia della guerra di posizione aprendo nuove vie di roccia e di ghiaccio, sovente sotto il piombo nemico (più di 60 nuove vie solo nelle Dolomiti), “sovrapponendo ai nobili ideali dell’alpinismo sportivo le cruente ragioni di quello offensivo”. Sovente in queste occasioni i rapporti gerarchici si invertivano: il soldato che nella vita civile faceva la guida alpina diventava il capo che guida il suo comandante sulle pareti e questi arrivava persino a perdonargli l’amicizia con la guida alpina nemica, a cui aveva confidato “che è già abbastanza faticoso vivere in montagna e che bisogna aiutarsi invece che spararsi”.
Ricca è la galleria degli straordinari “eroi” (“un esercito di diversi”) di questa epopea: dagli ufficiali di buona famiglia come l’Arnaldo Berti o il suo omologo Kaiserjager Felix Hecht, animati da nobili ideali, ai soldati semplici semi-illetterati (che però tengono un diario) come il Giacomo Perico o lo Stefano Equestri che “poteva solo obbedire cercando di stare vivo se gli riusciva”. O ancora dagli alpinisti borghesi (anch’essi ufficiali) come Umberto Balestrieri o Ugo Ottolenghi di Vallepiana, alle guide alpine come il valdostano Joseph Gaspard e i valtellinesi Giuseppe e G. Battista Compagnoni. Per arrivare a figure incredibili come quella del roveretano Francesco Laich, “il musicista che non doveva andare in guerra”, ma che suonò il violino e il saxofono sul Pasubio. E molti altri ancora, compresi i più noti Cesare Battisti, Damiano Chiesa ed Emilio Lussu. Alcuni di questi personaggi rimasero sui monti, talvolta insepolti. Altri tornarono a casa e l’ultimo capitolo racconta il dopo di questi sopravvissuti.
Con questo libro, che si legge d’un fiato, Enrico Camanni conferma le sue ben note doti di scrittore, che gli permettono di rendere viva una documentazione oltremodo ricca e in parte inedita.
Beppe Dematteis










