Robert Macfarlane, Luoghi selvaggi. In viaggio a piedi tra isole, vette, brughiere e foreste, Einaudi, Torino, 2011. 322 pagine, 21 euro.
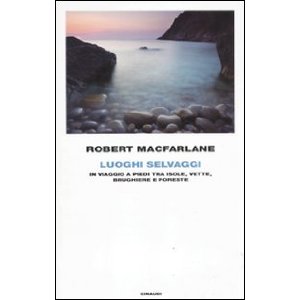
“Luoghi selvaggi” è l’appassionante diario di viaggio di un insegnante di Cambridge, è il racconto di uno scalatore con l’occhio del naturalista, è il taccuino di un ragazzo che scala gli alberi per gioco e per vedere il mondo di strade e palazzi sotto nuovi punti di vista, da cui sia di nuovo possibile volergli bene.
In Italia “docente universitario”, “1977” e “alpinista” sono tre espressioni distanti quanto “tapiro”, “0,4” e “parafulmine”, nel Regno Unito si trovano tutte e tre riunite nella biografia di Robert Macfarlane, 35 anni nel 2012, insegnante di letteratura inglese e scalatore con all’attivo un bel saggio sull’incanto esercitato dalle terre alte sugli esseri umani (“Come le montagne conquistarono gli uomini. Storia di una passione”, Mondadori 2005).
L’idea del nuovo libro è semplice e semplicemente impossibile: ricercare lembi di terra selvaggia in una delle aree più antropizzate del mondo, le isole britanniche. Partendo da un faggeto e passando per l’isola di Ynis Ennli, la brughiera di Rannoch Moor, la valle perduta di Bidean nam Bian, la magica casa-organismo di Walnut Tree Farm, Macfarlane disegna una preziosa mappa perduta dei luoghi che oggi nessuna carta riporta più: lande, grotte, picchi rocciosi, boschi, vie cave, valli e insenature. Sono i luoghi selvaggi dove Macfarlane passa, sosta, dorme, riflette (solo o in compagnia di compagni di viaggio così eccezionali che, a volte, meriterebbero un capitolo tutto per loro), annota. Un luogo dopo l’altro, di capitolo in capitolo, alla descrizione del viaggio si intrecciano note affascinanti di storia, geologia, etologia, ecologia, citazioni di filosofi e scalatori, biografie di scienziati, poeti e altre creature ugualmente prossime al sogno.
Il viaggio si conclude nel faggeto che ne aveva ispirato l’inizio, cui Macfarlane fa ritorno con un’idea di natura selvaggia profondamente trasformata. Partito in cerca di luoghi privi di tracce umane – aspri, solitari, inospitali – ha scoperto sul cammino un altro tipo di selvaticità: quella della vita naturale, la pura forza dell’esistenza organica in atto, vigorosa e caotica. Una selvaticità che non ha a che fare con l’asperità, ma con l’esuberanza, la vitalità, il gioco. La gramigna che spunta dalla crepa di un selciato, la radice che lacera impudente un guscio d’asfalto, la vita che brulica in una fenditura del calcare sono espressioni della natura selvaggia tanto quanto l’onda di tempesta o il fiocco di neve: «C’è tanto da imparare da un boschetto di mezzo ettaro ai margini della città quanto dalla vetta scheggiata del Ben Hope». E una delle prime lezioni da apprendere è che la selvaticità in sé non è in pericolo: ha fatto da preludio e sopravvivrà alla civiltà umana, che ha tutto il tempo di passare.
La prosa scorrevole e coinvolgente è tutta merito dell’autore o c’è anche lo zampino del traduttore (Duccio Sacchi)? Chissà. Di certo il libro regala a ogni pagina immagini buone per l’orecchio e per l’immaginazione: «baldorie di luce», su una terra che «rimbomba di quiete» solcata da «filari moicani» di siepi, dove talvolta si intende il «bubolìo» di uccelli che si alzano in volo «con un dolce fruscio di carte sfogliate».
Un testo che, per dirla con Herman Hesse, «all’inizio è stupore e è stupore alla fine». L’unico modo per farsi una ragione che dopo pagina 322 il racconto non continui, è assecondare il sano istinto di irrequieta curiosità vagabonda che Macfarlane trasmette, indossare un paio di scarpe comode e seguire il consiglio di John Muir: «Buttare una manciata di foglie di tè e un po’ di pane in un vecchio sacco e saltare il cancelletto di casa». La natura selvaggia, a saperla cercare, si trova tanto al Valentino che nella valle più remota delle Alpi.
Irene Borgna










