Antonio De Rossi, “La costruzione delle Alpi. Il Novecento e il modernismo alpino (1917 – 2017)”, Donzelli Editore, pp. XVI + 655, con 171 illustrazioni a colori f.t.
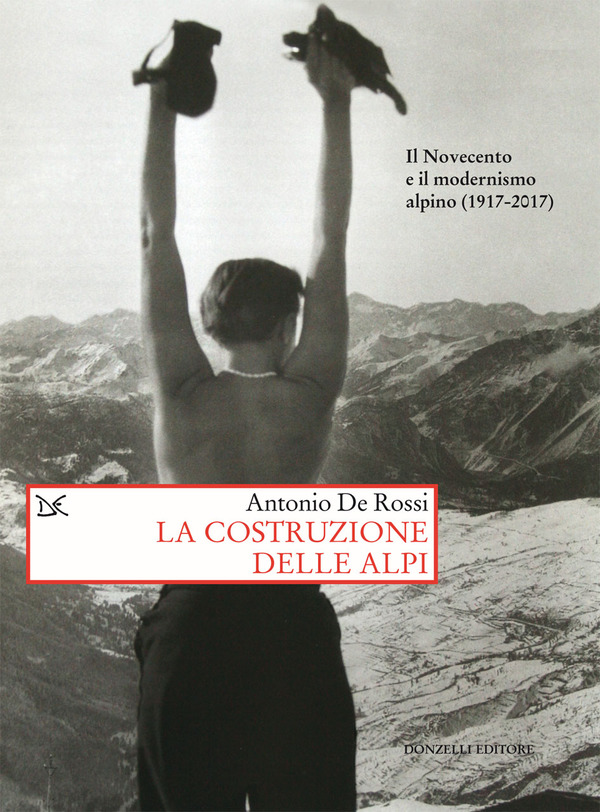
Il volume è l’attesa continuazione di “Immagini e scenari del pittoresco alpino (1773- 1914)” pubblicato da De Rossi presso lo stesso editore nel 2014. Anche in questo saggio per “costruzione delle Alpi” s’intendono sia le trasformazioni materiali dei contesti alpini, sia l’insieme delle rappresentazioni estetiche, concettuali e progettuali che le hanno indirizzate e guidate in un processo di interazione reciproca. A questa costruzione hanno partecipato letterati, pittori, designer pubblicitari, architetti, urbanisti, ingegneri, agronomi, antropologi, etnografi, geografi, sociologi, economisti, politici e altri ancora che possiamo trovare nelle 30 pagine dell’indice dei nomi (su due colonne) in fondo al volume, corrispondenti a centinaia di citazioni bibliografiche sparse nelle note. Il libro s’impone non solo per questo straordinario lavoro di scavo, ma anche e soprattutto per come l’autore ha saputo selezionare e padroneggiare questa massa enorme di informazioni, fino a ricavarne un discorso interpretativo di valore generale sul ruolo che le Alpi hanno avuto, hanno e si preparano ad avere per la società e per la cultura europea e globale. Anche perché, mentre il primo volume ci parlava dell’Europa partendo dalle Alpi Occidentali, nel secondo l’orizzonte si allarga ai territori di lingua tedesca delle Alpi centrali e orientali.
Un fil rouge attraversa tutta la narrazione, quello del passaggio dal “pittoresco alpino” (trattato nel precedente volume) al “modernismo alpino”, fin alla fase odierna della “patrimonializzazione”. Sono tre paradigmi, e tre scene teoricamente contrapposte, di una storia culturale, ambientale e sociale che fa da sfondo e da cornice ai diversi aspetti trattati nei capitoli. Il tema centrale, che occupa gran parte dell’opera, è quello dei cinque decenni (dagli anni ’20 ai ’70) del modernismo, cioè di un passato prossimo e di un immaginario troppo presto rimosso e rifiutato: “un’utopia rovesciata in ruggine” (p. 8), di cui però ancor oggi continuiamo, nel bene e nel male, a subire le conseguenze, mentre non possiamo sottrarci al fascino della sua eroica visione e forse anche di provarne – assieme all’autore (v. p. 34) – una certa nostalgia. Anche se il discours de Vallouise del presidente Giscard d’Estaing (23 agosto 1977) viene preso come episodio paradigmatico della chiusura di un ciclo, la periodizzazione delle due fasi – modernista e patrimonialista – presenta dei confini sfumati. Non solo esse si sovrappongono e in parte si compenetrano, ma la loro contrapposizione, così come quella con il precedente “pittoresco alpino”, non deve nascondere una continuità sottostante, quella per cui dal XIX secolo ad oggi ogni paradigma è stato “portatore di un dover essere della montagna che si traduceva in modelli quasi sempre di matrice urbana, cui il territorio alpino doveva aderire e soggiacere” (p. 613). Un grande pregio del libro è proprio quello di mostrarci la complessità di questa storia, con una narrazione che si sviluppa su piani interpretativi diversi, ne rivela le contraddizioni, in modo da obbligare il lettore a mettere in discussione le semplificazioni e le certezze della vulgata corrente. La chiarezza dell’esposizione, assieme all’efficacia delle numerose illustrazioni a colori, permettono anche al lettore non specialista di avvicinarsi con facilità e indubbio interesse al multiverso di una montagna di cui abbiamo tutti qualche esperienza appassionante, ma che in realtà stentiamo a capire nel suo significato complessivo.
Premesso che i contenuti dei vari capitoli meriterebbero una trattazione ben più ampia di quella consentita in questa recensione, proviamo a scorrerli rapidamente. Dopo una sintetica presentazione dei fatti in cui si manifesta il paradigma modernista e una sua prima concettualizzazione, il libro si articola in vari capitoli dedicati a mostrarne le molte facce e ad approfondirne i significati. I due primi – La montagna meccanizzata e L’ebbrezza dello sci – ci permettono di capire meglio, nei fatti, il significato di alcuni concetti presentati all’inizio (p. 31), come il sublime tecnologico (“una variante moderna della categoria del sublime”) e quello di “paesaggio alpino come un accadere” (…), sintesi di ambiente e azione” (“non più contemplazione di un quadro, esso presuppone il coinvolgimento diretto e attivo del soggetto (…) creando una sintesi paesaggistica di ordine superiore”). Vi concorrono soprattutto l’automobile e le nuove strade di altitudine con la loro “motorizzazione dello sguardo”, assieme agli impianti di risalita e alle bellezze della discesa, senza dimenticare i manifesti pubblicitari (“essenza del paesaggio del modernismo alpino”). Nei tre capitoli successivi l’autore affronta i temi più vicini alla sua preparazione accademica e professionale. Nel capitolo Le Alpi, laboratorio per l’architettura moderna tratta dell’evoluzione e diffusione dei due nuovi modelli ricettivi dello chalet du skieur e dello Sporthotel, poi del tema delle coperture, dell’interazione architettura – paesaggio, delle tecnologie costruttive e di alcune costruzioni socialmente e politicamente significative (le colonie montane e i sanatori), delle sperimentazioni di alta quota e dell’estetica dell’ingegneria montana, per finire con un’analisi della “modernità nella tradizione”, un tema che lega il “pittoresco” dell’Ottocento alla futura deriva patrimoniale. In Cantieri del modernismo alpino la lente si posa su Sestrière “città della neve” e su Bardonecchia “sole, neve, gioia di vivere”, poi sulla “modernissima” e “italianissima” Cervinia, per finire con un più largo giro d’orizzonte sulle Alpi occidentali e su Torino “capitale delle Alpi”: una “calamita industriale” che, mentre disgrega il tessuto sociale e produttivo delle sue montagne, ne fa una banlieue blanche al suo servizio. Con il capitolo “Una nuova urbanistica di alta quota” si va dalle prime cités de sports d’hiver, alla vicenda del pionieristico piano regolatore della valle d’Aosta promosso e coordinato da Adriano Olivetti, fin alla nascita delle stazioni integrate francesi ad opera di Michaud e Chappis (Courchevel, 1946) e alla comparsa delle stations village, che anticipano temi sviluppati poi nella fase successiva, mentre nel campo delle rappresentazioni compaiono quelle geoplastigrafiche, in cui eccelleranno Alessio Nebbia e Edi Consolo. Nel capitolo “La montagna all’inverso: ricerche e progetti per un territorio rurale” si indaga a fondo su studi, pratiche e progettualità che non riguardano solo le nuove forme e i nuovi ambienti insediativi, ma anche l’organizzazione territoriale, sociale, economica degli spazi alpini, attraverso le politiche del modernismo montano soprattutto di marca fascista, le tecniche e le pratiche che ne derivano. Si mette in rilievo il contributo, talvolta anche critico (Gribaudi, Gambi) della geografia umana e dell’etnografia, con approfondimenti sull’edilizia rurale tradizionale. Si parla della grande inchiesta sullo spopolamento montano, mettendone in evidenza il carattere innovativo di “descrizione progettuale”, si esaminano poi le ricadute di questa e di altre progettualità sugli interventi tecnici della bonifica montana idraulica, agro-pastorale e forestale, a cui si può far risalire l’idea della montagna come risorsa, riaffermatasi poi in anni recenti dopo il lungo oblio dei Trente glorieuses (1945-’75).
Alle ultime fasi della vicenda modernista – quelle che ne segnano l’apogeo, sancito dalla mondanità delle stazioni (“salotti traslati dalla città”), ma che mostrano al tempo stesso la sua insostenibilità – sono dedicati i tre capitoli: “L’età d’oro del modernismo alpino”, “Turismo e spopolamento, un paradigma totalizzante” e “Modernismo radicale. Le grandi imprese sportive” (ciclistiche, alpinistiche, automobilistiche…) hanno ormai trasformato le Alpi in “un palcoscenico per la modernità”, in cui “il tema del costruire in montagna rappresenta un fenomeno non soltanto architettonico, ma anche sociale e di costume”(p. 437). In esso giganteggia da noi la figura di Carlo Mollino, qui esaminata con grande maestria, in un contesto che comprende anche le opere di altri suoi colleghi (tra cui Chappis, Pradelle ecc.), tutti “capaci di fascinazioni estetiche in grado di creare nuovi valori aggiunti e d’uso da trasformare in inediti valori di scambio” (p. 440). All’interpretazione di questo apogeo contribuisce l’esame dei cinque convegni di Architettura montana di Bardonecchia (1952-’56), mentre a conclusione di tutti i precedenti discorsi, l’autore dedica un excursus di riflessione sui “ dispositivi dell’architettura moderna in montagna”. A partire dagli anni ’50 questa visione della montagna d’alta quota come “uno spazio vergine e laboriatoriale dove poter sperimentare senza limiti il cantiere di una nuova civilizzazione” (p.34), sarà sopraffatta dalla successiva ondata del turismo di massa e della conseguente urbanizzazione senza limiti, né forma, né carattere. In presenza di una fase accelerata di spopolamento, “la città traslata in montagna” andrà a ricolonizzare gli spazi lasciati liberi dai vecchi abitanti e dai vecchi lavori. Ma, mentre altera l’ambiente e cancella dal paesaggio la memoria di un mondo finito, questa urbanizzazione semina anche i dubbi e le inquietudini che alimenteranno la patrimonializzazione successiva. Nel frattempo però il modernismo montano doveva ancora trovare le sue più radicali espressioni nelle stazioni integrate francesi, nei loro più modesti, ma non meno interessanti, omologhi italiani (Pila, San Sicario, Cieloalto ecc.), nelle “mirabilia tecnologiche” delle grandi funivie come quelle del Monte Bianco e del Cervino e dei grandi trafori e viadotti autostradali.
L’ultimo capitolo esamina la fine della fase modernista a partire dall’opposizione del piccolo villaggio di Cervières allo ski total e dal già ricordato discours de Vallouise del 1977 (“non più l’antecedenza del turismo per risolvere il problema dello spopolamento, l’abitabilità della montagna come valore primo da cui far discendere tutte le altre azioni” p. 573). Sono prese di posizione programmatiche a loro volta anticipate da azioni di contrasto (gli ecomusei di G. H. Rivière, la Grande traversée del Alpes promossa da Ph. Lamour, ecc.) dalla nascita in Italia delle Comunità Montane (1971), da cambiamenti culturali (il “Nuovo Mattino” dell’arrampicata, il movimento occitano, la tutela dell’ambiente, l’interesse per le storie e le tradizioni locali ecc). Tutte cose allora molto nuove, attraverso cui maturerà il sistema di valori fondante il nuovo paradigma di patrimonializzazione delle Alpi. Negli anni successivi esso si esprimerà nelle forme architettoniche dei “villaggi inventati”, dell’urbanizzazione dolce (Chappis), nel ricupero del tipico e del tradizionale di ottocentesca memoria, da cui nascerà il trionfo del rustico e di tutto ciò che porterà alla “fine ingloriosa dello slancio eroico del modernismo alpino novecentesco” (p. 601). Seguono, con il titolo di “Conclusioni provvisorie”, i lineamenti del nuovo paradigma patrimonialista, quali emergono per contrasto con lo sfondo modernista: “ricchezza della diversità, dimensione ecologica, paesaggistica e storico-culturale, ritorno alla terra, nuova centralità dei “margini”, conservazione unita a valorizzazione delle risorse endogene, nuovi turismi, nuove visioni dell’abitare e dell’architettura ecc. Il capitolo si chiude con riflessioni sull’ambivalenza della tradizione reinventata come pretesto di pratiche esperienziali, sui rischi legati a una visione dei territori montani come “contenitori di risorse” e come valori di scambio soggetti a logiche esogene, sulla dimensione territorialista versus quella relazionale e multiscalare dello “sviluppo locale”, sui rapporti di forza tra le Alpi e gli interessi sovra locali, le nuove ibridazioni di urbano e montano, le Alpi come “immenso mosaico” eterogeneo fatto di grandi fondovalle urbanizzati, comprensori sciistici in crisi, “territori lenti”, spazi wilderness ecc. Una varietà che per uscire dal suo troppo lungo “divenire immobile” ha oggi “bisogno di un nuovo, difficile progetto”. Ma prima di decidere dove andare occorre sapere da dove si viene. Quindi cari politici, amministratori, esperti (soprattutto “patrimonialisti”), giornalisti e semplici cittadini, per favore, leggete questo libro.
Beppe Dematteis










